IL
PELLEGRINO DI
CIVATE
Casa
dell’Accoglienza
di Carlo Castagna
Estratto a cura della redazione
La prima edificazione del monastero di San Pietro al Monte sul pendio scosceso del Pedale, nella seconda metà dell’VIII secolo, non dava origine soltanto a quel complesso monastico che nella storia, da allora a oggi, si conobbe sotto il nome di Monastero prima di San Pietro e poi di San Pietro e Calocero di Civate. Infatti, essa determinò come sua conseguenza la realizzazione successiva di diversi oratori ed edifici di complemento funzionale e d’appoggio al monastero stesso, tra cui xenodochia o hospitia d’accoglienza e cura, destinati ai numerosi pellegrini e visitatori dello stesso complesso monastico.
Il
primo di questi particolari edifici d’appoggio sorse a debita
distanza dal primitivo insediamento, sulla bassa collina
verdeggiante, alle pendici del poggio del monte Pedale su cui
s’affaccia ancora oggi, mirabilmente, la splendida basilica di San
Pietro al Monte. La collina, discretamente boscosa, ancora oggi è
denominata Scola, derivando il toponimo millenario proprio dalla
presenza di una schola,
confraternita di disciplinati laici che ne curò la manutenzione nel
tempo. Si trattava di una costruzione rustica di discrete dimensioni,
con annesso un piccolo luogo di culto a oratorio
destinato alle pratiche religiose degli ospiti temporanei.
Di
esso oggi ancora rimane qualche traccia di muratura fra le poche
abitazioni rustiche e l’oratorio di S. Maria, poi di S. Rocco,
completamente trasformato nel XX secolo.
A
Civate v’è traccia sicura di almeno due hospitali.
Il più noto fu certamente il Pellegrino, sorto a partire già dal IX secolo, xenodochium adibito a ricovero gratuito per ospiti di vario genere. Fungeva pure da hospitale, a supporto dei viandanti, ma soprattutto dei devoti che, percorrendo da nord le derivazioni germaniche della Via Francigena, diretti a Roma dal centro Europa o provenendo da oriente per Campostela, sostavano presso l’antica abbazia di San Pietro e Calocero, venerando poi le sacre reliquie più antiche sul monte.
Nella
più antica ala settentrionale dell’edificio, o almeno la metà che
ne rimane oggi, si apre il portone d’ingresso, in semplice legno
massiccio, che s’affaccia sull’antica glarea strata
romana,
l’unica strada che allora, salendo dall’antica clavis
del ponte romano collocato sul Rio Torto, immetteva nel borgo murato.
Il
portone stesso non ha alcun segno distintivo,
neppure
stipiti in ghiandone o architrave con stemma distintivo. Ricorda i
semplici portoni delle contigue case contadine “a corte” della
zona. E infatti introduce a un passaggio sopra cui si trovano le
salae
pictae in
cui un tempo si aprivano solo strette finestrelle a sesto acuto. A
fianco del passaggio in lieve salita e acciottolato, si apre sulla
sinistra una stalla. Sulla destra del passaggio un altro ambiente ora
è stato trasformato in servizi. Precede il cortile un basso
porticato sostenuto da due colonne diseguali, realizzate con
materiale edilizio di recupero di costruzioni molto più antiche.
Segue
il grande salone “a
giorno” con camino.
 |
 |
Il
piano superiore è
composto da un ampio salone con due finestre che si aprono sul
cortile e le tracce della presenza, un tempo, di un camino. Scendendo
due gradini si accede a un ambiente più angusto sulla cui limitata
parete meridionale si ritrova ancora un’immagine di Sant’Agata
accanto a una Santa Barbara. Da qui si accede alle due meravigliose
salae
pictae. Le
due salae
sono
un’esplosione di colori in cui si svolgono due cicli d’affreschi
cortesi e di caccia, tra festoni, nastri, stemmi nobiliari dei
Visconti
e
dei De
Madiis con
simbologie sacre da cui si evince il costante riferimento alla corte
visconteo sforzesca. Si potrebbe presumere che la grande sala con
camino servisse da dormitorio comune, mentre le salae
pictae fossero
riservate agli ospiti di riguardo.
Ora
il Pellegrino
è
affidato alla preziosa cura, manutenzione, tutela e promozione
culturale offerta dai giovani dell’Associazione Luce Nascosta.
Uno
xenodochium,
meno conosciuto, è appena accennato in località Pozzo. Collocato in
cima all’erta, probabilmente aveva sostituito un’antica taberna
romana, semplice osteria senza pretese presso cui viaggiatori e
carrettieri, sudati e affaticati dalla salita impegnativa, sostavano
volentieri per bere un potus,
un bel bicchiere di vino denso e resinoso.
L’edificio si affacciava
direttamente sul percorso della glarea
strata romana che,
risalendo la collina di Civate attraverso via
del ponte e cà
nova, attraversava
come oggi il borgo
murato fino sull’erta.
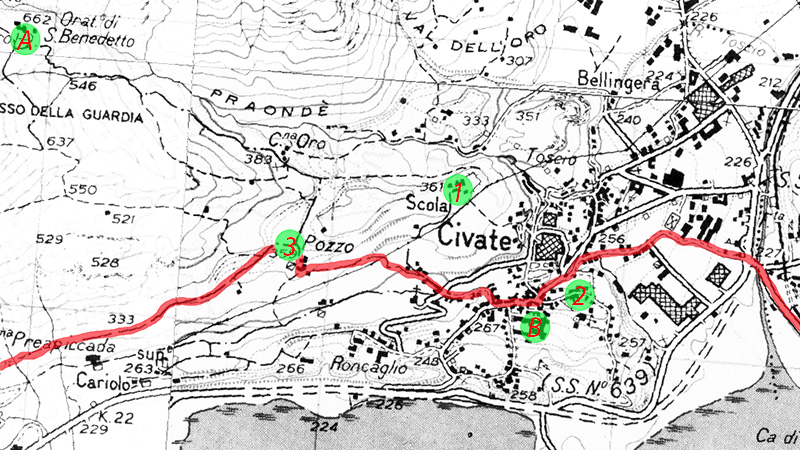
A: San Pietro al Monte, B: San Calocero, 1: Hospitium primitivo, 2: Pellegrino, 3: Pozzo
Da lì il percorso continuava costeggiando a nord i laghi d’Annone e Pusiano per dirigere verso Como, ma al trivium di Incino si diramava anche a sud per raggiungere Giussano, quindi verso Milano attraverso Seregno, Desio, Nova Milanese e per Monza, seguendo la direttiva di Carate.
Leggi QUI
l’articolo completo in PDF
|
Per una trattazione completa storica, architettonica, artistica e del restauro: …
RE VESCOVI ABATI, VIANDANTI E
PELLEGRINI Per
le visite: http://www.lucenascosta.it +39 3341334856 |
