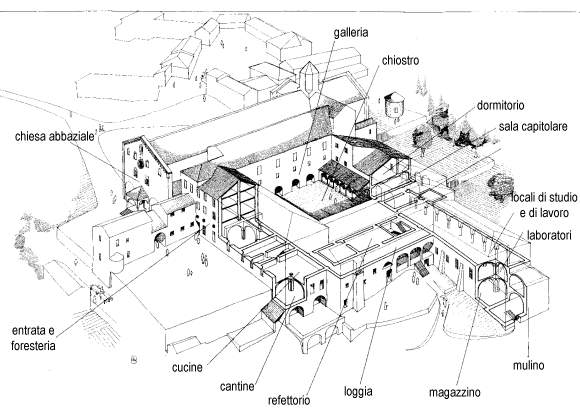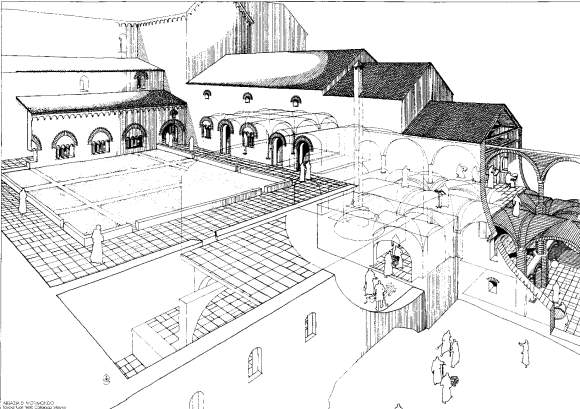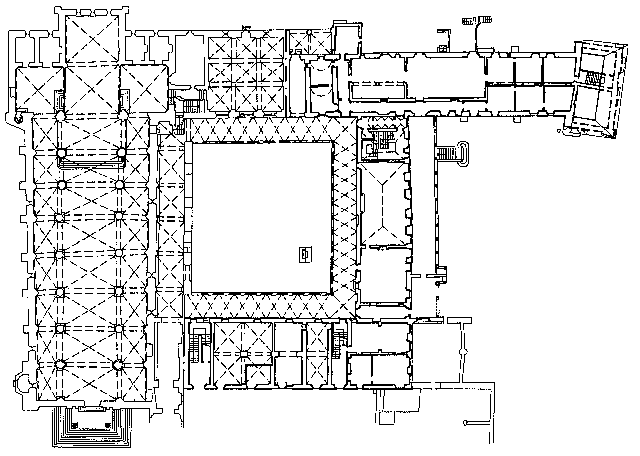Morimondo
LA COSTRUZIONE DEL MONASTERO
 La
chiesa e il monastero dovevano essere costruiti in un disegno uniforme
per tutte le fondazioni cistercense, le uniche varianti ammesse erano quelle
dettate dalla conformazione del terreno. Anche i progettisti e gli architetti
erano i monaci stessi. Per la costruzione del monastero non mancarono donazione
ed offerte di benefattori insigni. Inizialmente le strutture del chiostro
erano in legno, a parte il dormitorio la sala capitolare che erano in muratura.
Intorno al chiostro ci sono sale di "riunione", le sale di lavoro dei monaci,
la biblioteca e il refettorio. Modifiche visibili ancora oggi sono state
effettuate nel Cinquecento dai fiorentini e nel Seicento dall'abate Libanorio.
Nella parte orientale troviamo l'ospedale, le cantine e le stalle. Il monastero
è una costruzione modesta, se paragonata alle altre abbazie della
Lombardia e dell'estero.
La
chiesa e il monastero dovevano essere costruiti in un disegno uniforme
per tutte le fondazioni cistercense, le uniche varianti ammesse erano quelle
dettate dalla conformazione del terreno. Anche i progettisti e gli architetti
erano i monaci stessi. Per la costruzione del monastero non mancarono donazione
ed offerte di benefattori insigni. Inizialmente le strutture del chiostro
erano in legno, a parte il dormitorio la sala capitolare che erano in muratura.
Intorno al chiostro ci sono sale di "riunione", le sale di lavoro dei monaci,
la biblioteca e il refettorio. Modifiche visibili ancora oggi sono state
effettuate nel Cinquecento dai fiorentini e nel Seicento dall'abate Libanorio.
Nella parte orientale troviamo l'ospedale, le cantine e le stalle. Il monastero
è una costruzione modesta, se paragonata alle altre abbazie della
Lombardia e dell'estero.
LA COSTRUZIONE DELLA CHIESA ABBAZIALE
La sua costruzione è posteriore a quella del monastero. I
monaci desideravano una chiesa grande, spaziosa, luminosa che restasse
per molti secoli successivi. L'architetto rimase sconosciuto; gli abbellimenti
artistici furono eseguiti dai celebri maestri Comacini. La costruzione
della chiesa durò quasi un secolo, a causa della difficoltà
sorte con il clero di Casorate e delle incursioni nemiche, la più
grave delle quali fu quella del 1937.
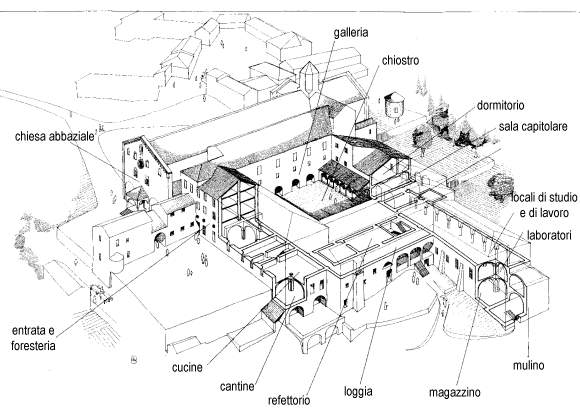
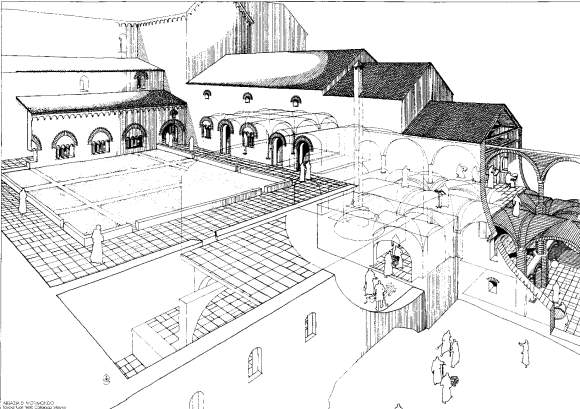
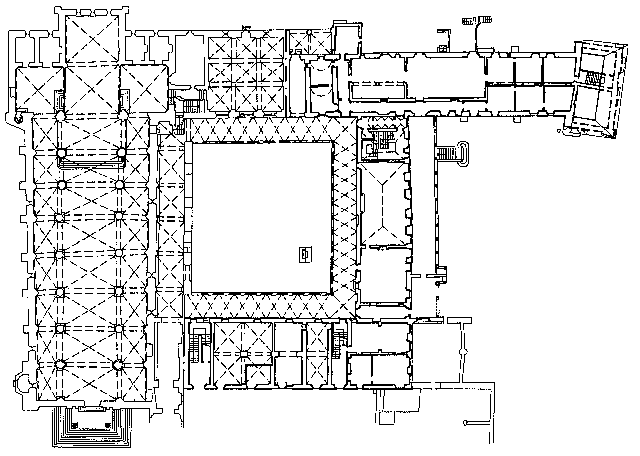
La chiesa di Morimondo riprende gli elementi fondamentali dell'architettura
monastica cistercense e costituisce un esempio significativo del Gotico
italiano. La chiesa abbaziale doveva essere sempre grande, slanciata e
ben illuminata. Aveva l'abside rivolto vrso oriente e il cento del coro
che terminava nell'altare maggiore. La chiesa vista dal fondo, sembrava
immensa: i capitelli di pietra e gli spazi di intonaco bianco, intercalati
al rosso del cotto, le danno un senso di leggerezza.
Le vicende storiche dell'abbazia furono lunghe e complesse: si alternano
momenti di grande stabilità e splendore a periodi di decadenza.
Fra questi vanno ricordati soprattutto i secoli XIII°, XV°, XVIII°
ACQUAFREDDA E CASALVOLONE FILIAZIONI DI MORIMONDO
Il periodo di massimo splendore della nostra
abbazia si ha nei primi decenni del Duecento. Lo splendore non derivava
specialmente dal numero e dalla qualità delle persone che abitavano
il monastero, dei monaci e degli abati che si distinguevano per pietà,
spirito religioso, cultura teologica, caritrà e generosità
verso i poveri, abilità diplomatica per superare i continui pericoli
di una politica che divideva le città e i popoli.
Un segno dell'importanza che la nostra abbazia
si era acquistata nella Chiesa e della stima che ovunque riscuoteva è
la presenza a Morimondo, nel 1274, del Papa Gregorio X e di san
Bonaventura di Bagnoregio in viaggio verso Lione. Due anni prima era
passato a morimondo, ospite dei monaci, il re Filippo III di Francia, detto
l'Ardito,. Tutte le grandi abbazie del medioevo erano punti di riferimento
obbligatori per i lunghi viaggi, ma non quelle isolate e fuori mano come
quella di Morimondo. La presenza di questi illustri ospiti era conseguenza
non di necessità ma di scelta volontaria suggerita dalla stima e
dalla simpatia.
Anche Morimondo ebbe presto le sue figliazioni,
cioè abbazie fondate e dirette da monaci e abati provenienti dall'abbazia-madre.
Morimondo fece a tempo ad averne due, ad Acquafredda da una sorgente
d'acqua freschissima che sgorgava nelle vicinanze. La chiesa era dedicata
alla Madonna, a san Pietro Apostolo e a sant'Agrippino. Oggi Acquafredda
è diventata un luogo di convegni e di preghiera sotto la direzione
dei padri cappuccini di Milano.
Casalvolone fu fondata dai morimondesi
nel 1169. Posta tra Vercelli e Novara, Casalvolone si ytrovò spesse
volte coinvolta nelle controversie e lotte che dividevano le due città
e non sempre le fu facile conservare la tanto desiderata e tanto opportuna
neutralità.
Verso la fine del Quattrocento èpare
che non vi fossero più monaci e che gli edifici fossero passati
interamente nelle mani dei commendatori. Oggi sul posto dell'antica abbazia
non esiste più nulla, neppure le rovine del monastero e della chiesa.
L'OPERA DEI MONACI FIORENTINI A MORIMONDO
L'istituzione della commenda a Morimondo portò qualche danno,
ma anche qualche vantaggio. La parola "commenda" in latino vuol dire "affidamento".
L'abbazia era affidata ad un personaggio estraneo alla comunità,
ecclesiastico o laico, che prendeva il titolo d'abate commendatario. Egli
aveva autorità assoluta sul monastero e sui monaci. A capo della
comunità restava un priore non più abbatterono poteri molto
limitativi commendatario poteva introdurre riforme o modificazioni a piacimento,
abitualmente non risiedeva mai, o di rado, nella sua abbazia, ma ne percepiva
tutte le rendite lasciando alla comunità il puro necessario per
vivere. Subentrò nella commenda morimondese anche Giovani de
Medici, figli del celebre Lorenzo il Magnifico, futuro papa col nome
di Leone X. Al de Medici erano già state affidate altre abbazie,
Montecassino, Passignano e l'arcivescovado di Aix-en-Provence.
Il commendatario Giovanni de Medici nel 1491 Fece arrivare a Morimondo
un gruppo di monaci cistercensi di Badia a Settimo presso Firenze.
Fu questo il suo intervento più importante che doveva avere tante
conseguenze positive nella nostra storia. La Badia a settimo godeva alla
fine del '400 una meritata fama di regolarità e di fervore, dopo
che il cardinale Domenico Capranica vi aveva portato una benefica riforma
materiale e morale. I monaci di Settimo erano già stati inviati
dal papa in altri monasteri per riformarli e riportarli all'antico fervore,
ma non sempre avevano trovato buona accoglienza. Tra le abbazie da riformare,
a cui furono inviati i Settimiani, c'era anche Chiaravalle milanese, ma
la reazione dei monaci fu negativa, ma fu condiscendente a Morimondo. La
riforma settimiana si esplicò nel ritorno alla regolarità
primitiva, all'osservanza dell'orario e delle norme stabilite dalla Regola
cistercense e nell'aumento delle vocazioni, nell'incremento del prestigio
e della fama del monastero. Di questa riforma interna i documenti arrivati
fino a noi dicono poco o nulla, ma non possiamo dubitarne. Più documentata
è la riforma "esterna" in campo amministrativo, materiale artistico.
Nel campo amministrativo ricordiamo la grangia detta " La Fiorentina "da
essi istituita, ma l'influsso dei fiorentini si manifestò soprattutto
in quello artistico.
Ci fu un'ondata di classicismo e di ammodernamento dell'arte. Al
vecchio stile gotico s'aggiunse lo stile rinascimentale che aveva trovato
buona accoglienza a Milano per la presenza di Bramante e di Leonardo. Le
opere che rimangono dimostrano buon gusto linea sobria ed elegante ed una
felice fusione del vecchio col nuovo Queste opere sono principalmente tre:
il portale, il chiostro e il coro. Segno del rinascimento a M. è
la porta rettangolare della sacrestia e i fregi con palmette e delfini.
Il chiostro fu rifatto in muratura con eleganti colonne in granito uniformi
sormontate da un capitello di marmo bianco di bellissimo effetto. Col chiostro
fu restaurata anche la sala capitolare sulla stessa linea rinascimentale.
L'opera principale dei monaci fiorentini è il nuovo monumentale
coro in legno intarsiato in sostituzione di quello antico, che risaliva
a quattro secoli prima. L'antico coro, secondo la buona norma cistercense
ancora conservata nelle diverse chiese dell'Ordine come a Chiaravalle,
era costruito davanti, non dietro all'altare maggiore, formando quasi un
tutt'uno con esso. I monaci vollero sistemarlo nell'abside, dietro all'altare
maggiore con un disegno più ampio. Il coro termina dalla parte dell'altare
con due maestose porte di noce terminanti in alto con uno zoccolo di legno
destinato a sostenere due statue, che sono sparite, una rappresentava S.
Benedetto, l'altra S. Bernardo. S. Carlo Borromeo e Morimondo.
La storia ecclesiastica e civile di Milano nella seconda metà
del '500 è dominata dall'imponente figura di S. Carlo Borromeo.
E' lui che ha dato alla città e alla diocesi una configurazione
nuova e duratura. La sua inflessibilità fu sperimentata più
volte anche dai monaci di Morimondo. Date le difficoltà finanziarie
dell'Ospedale Maggiore di Milano, allora amministrato da ufficiali
spagnoli che ne avevano dilapidato i fondi, e data la vastità terriera
di Morimondo diventata ormai superflua per il mantenimento dei monaci e
la manutenzione del monastero, S. Carlo trasferì, all'Ospedale Maggiore,
quasi tutti i beni immobili del monastero, lasciando ai monaci soltanto
la grangia intorno alla chiesa, l'attuale Morimondo. Un secondo intervento
di S. Carlo, o meglio uno scontro che durò diversi anni, riguardava
il rito ambrosiano che egli voleva imporre ai monaci, fino allora rimasti
fedeli al rito romano. I monaci continuarono per i cinquant'anni successivi
alla morte di S. Carlo a pregare e ad ufficiare in rito romano. Il rito
ambrosiano fu adottato quando Morimondo divenne parrocchia della diocesi.
I monaci non erano entusiasti della novità. L'Ordine cistercense
era di vita contemplativa, non attiva. La cura d'anime e la parrocchia
esulavano dalla Regola di S. Bernardo ed erano lasciate al clero diocesano.
La parrocchia comprendeva anche la grangia della fiorentina, di Bugo, di
Ceselle, di Basiano, delle Cerrine del Lasso, di Ticinello, di Coronate
e di Fallavecchia. S. Carlo fu a Morimondo il 10 luglio 1575.
LA DECADENZA E LE SUE CAUSE
Quando si parla di decadenza dei monasteri
o di altri istituti religiosi, di solito la colpa è gettata tutta
sui monaci stessi che, dimentichi dei loro voti, vengono meno ai loro ideali
e alla loro promessa.
Nel caso di Morimondo dobbiamo tener conto
di molti altri fattori esterni ed interni: altre cinque incursioni: In
più l, la situazione precaria e meno sicura in cui la comunità
si era venuta a trovare scoraggiava quelli che avrebbero voluto entrare
a farvi parte.
La crisi di vocazioni e la diminuizione del
numero dei monaci coincide con la crisi del feudalesimo. Assistiamo nel
Duecento alla nascita dei comuni italiani. Il popolo prende in quel periodo
sempre più coscienza di sé stesso e vuole governarsi da sé.
I monasteri erano stati fino allora la difesa più efficace contro
l'invadenza dei feudatari, ma ora, diminuita l'influenza del feudalesimo,
diminuisce anche l'importanza dei monasteri. Altro fattore esterno di decadenza
è la grande peset del 1347-1348. Città intere furono distrutte
e rifatte nuove, monasteri decimati, delle generazioni intere soppresse.
La peste ebbe conseguenze fisiche, economiche, demografiche e morali in
tutta la società, non esclusi i monasteri e le comunità religiose.
La Regola fu attenuata e modificata, i pasti e gli orari ridotti. Si ha
perciò un allentamento, un certo rilassamento della regola primitiva
che in base al principio: favores sunt ampliandi, le concessioni favorevoli
devono sempre aumentare.
Un terzo fattore esterno di decadenza è
il grande scisma d'occidente che divise l'Europa cristiana tra due Papi
rivali.
Per Morimondo in particolare c'è un
altro fattore che lo interessa da vicino: con l'unificazione politica della
Lombardia sotto i Torriani e i Visconti le città lobarde non hanno
più nè ragione né possibilità di combattersi
per contendersi una supremazia. L'importanza di Morimondo sia politica
che economica derivava in gran parte della sua posizione strategica tra
Milano e Pavia e dall'interessa che l'una e l'altra avevano di tenersela
legata con favori e privilegi. Ma chiusa e superata questa contingenza
storica era giocoforza che anche l'abbazia diventasse come le altre, una
delle tante.
Un altro fattore di decadenza, certamente il
più fatale di tutti, fu il passaggio dell'abbazia sotto la così
detta Commenda (affidamento).
Morimondo fu dato in commenda a Giovanni Visconti,
arcivescovo di Milano, nel 1450. Verso la fine del secolo XV i monaci di
Morimondo erano appena una decina e venne la Sacra Rota di Roma a sopprimere
l'abbazia conferendola in commenda al Visconti.
VERSO TEMPI NUOVI
Degrado e rovina del Monastero e richiesta di restauro al Governo
che però rimane indifferente.
1909 : l'Ufficio Regionale dona 6000 £ per la manutenzione
riparazione tetto, tiburio, torre campanaria, facciata
1932 : è costituito il Comitato per i lavori di Morimondo
1948 : i restauri vengono assunti dalla Sovraintendenza per i monumenti
della Lombardia

1952 : arrivano a Morimondo i padri Oblati di Maria Vergine
---- cura della parrocchia. Termina la divisione fra la proprietà
della Chiesa e dei Camolli Durante i lavori di restauro torna alla luce
un prezioso affresco, "L'Annunciazione di Maria", che si trova in ottime
condizioni
OGGI : la Chiesa appare nella purezza
della linea duecntesca, nuda nei suoi mattoni a vista di un rosso vivo
che nulla hanno perduto dal loro colore e dal loro calore antico, grandiosa
e imponente ma anche elegante e slanciata.
=========================
 La
chiesa e il monastero dovevano essere costruiti in un disegno uniforme
per tutte le fondazioni cistercense, le uniche varianti ammesse erano quelle
dettate dalla conformazione del terreno. Anche i progettisti e gli architetti
erano i monaci stessi. Per la costruzione del monastero non mancarono donazione
ed offerte di benefattori insigni. Inizialmente le strutture del chiostro
erano in legno, a parte il dormitorio la sala capitolare che erano in muratura.
Intorno al chiostro ci sono sale di "riunione", le sale di lavoro dei monaci,
la biblioteca e il refettorio. Modifiche visibili ancora oggi sono state
effettuate nel Cinquecento dai fiorentini e nel Seicento dall'abate Libanorio.
Nella parte orientale troviamo l'ospedale, le cantine e le stalle. Il monastero
è una costruzione modesta, se paragonata alle altre abbazie della
Lombardia e dell'estero.
La
chiesa e il monastero dovevano essere costruiti in un disegno uniforme
per tutte le fondazioni cistercense, le uniche varianti ammesse erano quelle
dettate dalla conformazione del terreno. Anche i progettisti e gli architetti
erano i monaci stessi. Per la costruzione del monastero non mancarono donazione
ed offerte di benefattori insigni. Inizialmente le strutture del chiostro
erano in legno, a parte il dormitorio la sala capitolare che erano in muratura.
Intorno al chiostro ci sono sale di "riunione", le sale di lavoro dei monaci,
la biblioteca e il refettorio. Modifiche visibili ancora oggi sono state
effettuate nel Cinquecento dai fiorentini e nel Seicento dall'abate Libanorio.
Nella parte orientale troviamo l'ospedale, le cantine e le stalle. Il monastero
è una costruzione modesta, se paragonata alle altre abbazie della
Lombardia e dell'estero.