| The birth of cistercian architecture |
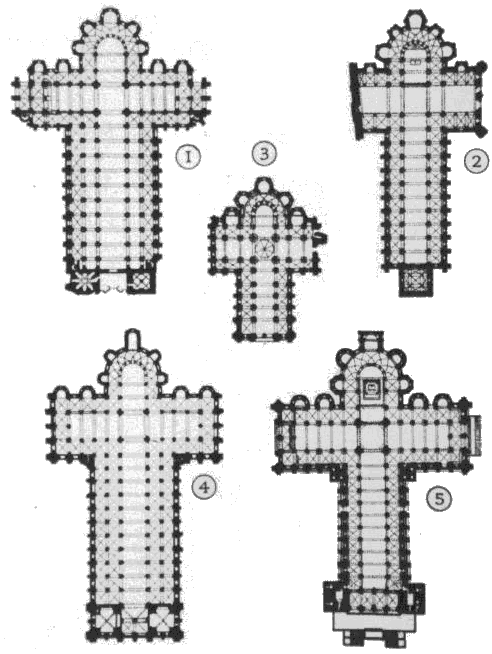
| The style |
|
E' questa la nuova tendenza, opposta alla precedente che ha come
modello di riferimento Pontigny, chiesa a tre navate, con volte a crociera
costolonata e coro a deambulatorio. Nonostante il passaggio da un sistema
di volte a botte ad una voltatura a crociera, con la conseguente possibilità
di rialzare e illuminare direttamente la navata centrale nulla c'è
di fondamentalmente estraneo al contemporaneo protogotico borgognone, tranne
forse il sistema di contrafforti esterni del coro della stessa Pontigny,
terminato alla fine del Duecento. Nel 1235 viene invece consacrata l'abbazia
di Royaumont, fondazione di Luigi IX e il Gotico "da cattedrale" viene
a combinarsi con la tradizionale sobrietà architettonica cistercense
in costruzioni dotate di un grande coro e cappelle radiali, distinte da
un evidente gigantismo.
| Decoration patterns in cistercian architecture |
Ciascun elemento, decorativo oltre al valore funzionale, assume il ruolo di scandire ed esaltare la logica assoluta dell'unita architettonica. Qui si può parlare di unitarietà: questo non impedisce l'individuazione di tre fasi, "bernardina", "postbernardina" (dalla 2° metà del secolo XII) e una terza. Permeabile agli influssi del gotico maturo, dalla metà del XIII sec..
La prima fase prevede una assoluta purezza e razionalità geometrica degli spazi e assenza della componente decorativa (dove è presente, si esprime in forme geometrizzate e semplificate). Abbiamo ad esempio i semplici capitelli a dado scantonato o a motivi vegetali che di norma si compongono di quattro foglie d'acqua, lanceolate o lisce, in corrispondenza dell'abaco spesso schematizzate e riassunte in vere e proprie forme geometriche. L'abbazia di Fontenay deve considerarsi paradigmatica, oltre che per l'impianto architettonico, per la decorazione che contiene la gran parte del repertorio dei temi decorativi della prima scultura cistercense. Nell'abbazia borgognona, si trovano capitelli fogliati e puramente geometrici o motivi a palmetta o a rosetta; anch'essi sono CONCEPITI COME SEGNI, FIGURE SIGNIFICANTI. Questa essenzialità non si sviluppa, tuttavia come programma estetico, bensì come riflesso di dettami di ordine morale. Gli eccessi e le fantasticherie nelle chiese dell'epoca non avevano ragione d'esistere nell'abbazia perché la loro presenza avrebbe costituito motivo di distrazione per la preghiera e la meditazione del monaco, inoltre superfluitas e curiositas conducono a uno stimolo di sensi che non si addicono all'attività intellettuale e all'etica monastica improntata sul desiderio di una vita autenticamente evangelica, integrale e radicale. Sono bandite tre categorie iconografiche: forme ibride e mostruose, animali e attività umane. Eliminare il superfluo consente di ridurre la forma alla sua essenza più pura e quindi più vicina alla perfezione divina.
Nella II fase questo totale e assoluto rigore si stempera col passare degli anni; questo è dovuto al crescente adeguamento dei cantieri-scuola delle nascenti fondazioni alla singole tradizioni locali. Dagli anni 60-70 del XII sec. il repertorio tematico e formale si amplia e diversifica. Parallelamente a suddetto processo, si riscontra talvolta la presenza di elementi di valore simbolico-religioso (a Chiaravalle di Fiastra v'è un capitello sulla cui faccia laterale è scolpito un pesce). Nelle abbazie provenzali, si moltiplicano gli esempi realizzati attraverso un rielaborazione del tipo corinzio classico; l'ambito borgognone fu un importante bacino di ispirazione per le maestranze dell'Ordine. I Cistercensi presero a prestito motivi e tipologie decorative, ma il tutto fu sempre interpretato secondo i medesimi principi di rigore espressivo precedenti. Ad esempio la componente degli elementi geometrici non scomparve, a ribadire quanto la decorazione di matrice cistercense non assuma mai carattere esornativo, ma sia portatrice ed espressione di un programma educativo e di un esercizio intellettuale legato alla conoscenza per aenigmata .
La terza fase si ha partire nei primi anni del Duecento, in concomitanza al grande sviluppo del Gotico nelle cattedrali, il repertorio si arricchì con l'inserimento di temi naturalistici, con un attenzione quasi scientifica .Le caratteristiche di questi nuovi elementi sono ancora l'estrema essenzialità formale e il loro inserimento in forme camuffate e il loro porsi in chiave ironica rispetto alla forma in cui sono collocati (talvolta l'elemento iconico si sostituì a quello architettonico). Di rado la figura umana si trova isolata e laddove compare assume un forte significato simbolico; spesso abbiamo elementi che vogliono alludere ad alcuni momenti delle attività quotidiane dell'abbazia. A partire dalla metà del XIII sec. la decorazione non presentò più quei caratteri che la rendevano peculiare; il rigore formale era ormai scomparso e i temi decorativi che in precedenza mancavano o erano l'eccezione, sembrano rappresentare la regola.
Nella disposizione degli edifici conventuali, rigide direttive organizzavano
una logica e pratica funzione degli spazi. Alla chiesa di solito sul fianco
meridionale, era affiancato il chiostro, di pianta quadrata, ed intorno
a questo si succedevano gli altri ambienti, la sacrestia, la sala capitolare,
il parlatorio, il calefactorium e lo scriptorium sul lato orientale; cucina
e refettorio sul meridionale; ambienti di servizio e di raccolta delle
provvigioni e talora xenodochio sul quello occidentale. Al piano superiore
i dormitori per i monaci e opposti, per i conversi. La costruzione procedeva
lentamente e le parti prossime alla chiesa e i dormitori erano i primi
ad essere completati, in seguito si facevano le gallerie del chiostro e
la parte restante. Le comunità monastiche erano centri estremamente
attivi di vita spirituale ed intellettuale oltre che fucine delle più
varie attività manuali.
| The end and heritage |
1. Silvacane in Provenza, con pianta carica di assonanze bernardine - basse volte a botte, e sempici membrature - ma estranea alla linea di Clairvaux;
2. Silvacanès in Linguadoca, atipica abbazia dalla larghissima navata unica con cappelle continue che venne a costituire una tipologia molto diffusa all'epoca del Gotico maturo;
3. Noirlac nel Berry, pura interpretazione dell'abbazia Cistercense.
L'abbazia di Noirlac è costituita innanzitutto dalla chiesa abbaziale, a croce latina con una navata a otto campate, terminante in un santuario ad abside piatta a cui si arriva passando successivamente per il coro dei conversi, il coro dei malati e quello dei monaci. All'estremità del braccio nord del transetto v'era la "porta dei morti" che dava accesso al cimitero situato dietro l'abside della chiesa, all'esterno. Uscendo invece dal braccio sud del transetto si accede alla sala del capitolo che ha un'architettura molto più curata: le volte della copertura poggiano su crociere di ogive e il tutto è sostenuto da due piloni a faccette multiple con capitelli a "foglie acquatriche". Questa sala è poi legata al chiostro da una galleria ad arcate. Il chiostro si dispone attorno ad un pozzo con gallerie fiancheggiate da arcate e con capitelli in stile romanico, ma pure gotico nella parte est; questa frammistione si spiega col fatto che il chiostro fu costruito in vari periodi e fu anche ingrandito successivamente. Vi è una cantina piano terra dell'edificio destinato al dormitorio (anzi ai due dormitori, per i monaci e per i conversi) di notevole altezza, con aperture chiuse originariamente da tele oleate; essa era destinata alla conservazione delle granaglie, della frutta e del vino. Sempre a pianoterra si trova il refettorio, di ampie dimensioni e illuminato da quattro arche i forma di lancia, sormontato da due rose; nel Medioevo comunicava con la cucina, andata distrutta nel Settecento. Al primo piano c'è infine la sala dei monaci, dove essi studiavano e copiavano i testi sacri e trascorrevano la maggior parte del tempo; per questo vicino doveva trovarsi il riscaldatoio, ora scomparso
· Spagna e Portogallo: nei territori da poco sottratti ai Mori il panorama artistico tardoromanico è fortemente permeato dalla cultura francese. In Santes Creus la navata centrale è in alzata e vi sono ricavate delle aperture, pur mantenendo la copertura a volte a botte. L'abbazia di Alcobaça presenta invece un progetto ispirato a Pontigny, con un grande coro a deambulatorio. · Svizzera: le basse strutture a tre navate su semplici pilastri, coperte a botte, unite di transetto a terminazione piana, sono delle vere e proprie "officine per pregare", quasi immuni da decorazione scultorea, come Bonmont. Esempi simili si possono trovare anche in Svezia. · Inghilterra e Irlanda: è da sottolineare la precocità di alcune fondazioni di età bernardina come Rievaulx e Fountains. L'aspetto assunto dall'edilizia cistercense risulta fortemente modificato dal gusto e dalle consuetudini locali: seppure costruite seguendo uno schema ad quadratum sono allungate nelle dimensioni, possiedono cappelle terminali calate e presentavano in origine copertura piana nella navata centrale e volte a botte trasverse, o a crociera costolonata in una fase più matura; nelle navatelle. L'Irlanda invece rimane più fedel ai prototipi borgognoni. Inoltre, in Inghilterra, grazie a numerose fonti documentate sono stati rintracciati i nomi dei costruttori, per lo più monaci.
· AREA TEDESCA: fino al Duecento avanzato permane un gusto fondamentalmente romanico che applicava arcate su colonne come nel caso di Eberbach. Alla metà del XIII sec. risale la facciata della chiesa abbaziale di Heiligenkreuz, tripartita, a salienti e cuspidata che ripeteva forme decorative di tradizione romanica come le cornici ad archetti. · EST EUROPEO: e maggiore la resistenza all'introduzione di una pianta concepita in toto secondo il modello bernardino, in favore dell'accoglimento delle tipologie locali (es. Sticna in Slovenia).In Polonia è evidente un elementarizzazione formale nelle basse costruzione su pilastri, coperte da volte a crociera, con una semplice ma interessante decorazione scultorea per lo più su temi vegetali.